Bucoliche e Georgiche di Virgilio: analisi
Bucoliche e Georgiche di Virgilio: nalisi contenutistica e storica delle due opere del poeta latino con somiglianze e differenze

Bucoliche e Georgiche

Dal 42 al 39 a.C. Virgilio compose le “Bucoliche” (boukoloi = pastori), una raccolta di 10 ecloghe o “canti scelti” in esametri. Esse furono composte negli anni dello scontro di Filippi (Brutto e Cassio contro Antonio e Ottaviano). In esse Virgilio riporta inoltre la sua esperienza personale legata alla confisca dei terreni agricoli destinati ai milites.
Le bucoliche sono appunto organizzate in 10 ecloghe con struttura dialogica (Amebea) durante la quale i pastori discorrono tra loro. I contenuti principali sono:
- Amarezza per la confisca dei terreni agricoli,
- L’amore infelice,
- Poesia tenue e leggera,
- Mondo pastorale,
- La nascita di un puer e che darà inizio all’età dell’oro,
- L’elogio a tutto il mondo bucolico,
- L’agone poetico,
- La consolatio.
Temi dell'Arcadia
Nelle Bucoliche la natura, e in particolare il paesaggio agreste è visto come un locus amoenus che garantisce serenità e pace con carattere principalmente esornativo. Nella composizione Virgilio si rifà alla tradizione di Teocrito, considerato vero e proprio inventor del genere pastorale. Il paesaggio a cui Virgilio si ispira è quello dell’Arcadia, la regione greca del Peloponneso, peculiare per la presenza dei pastori. Il paesaggio agreste rappresenta allora per Virgilio lo strumento di sublimazione dei dolori e della malinconia, dove allontanare le contraddizioni e le tensioni della realtà. Virgilio riesce così a creare una straordinaria sintesi tra realtà e sogno.
La poesia per Virgilio assume fondamentale importanza; infatti essa è vista come il più grande tra gli strumenti dell’uomo, che si eleva ad un livello maggiore rispetto alle crudeltà e violenze umane.
Un topos letterario della poesia virgiliana è inoltre l’amore infelice, visto come dementia et furor, molto presente nella poesia pastorale greca e latina. Nella composizione non mancano tuttavia excursus sulla politica del tempo, sulle guerre civili e sulle confische dei terreni, che determinano un’atmosfera malinconica e dolente all’interno degli idilli pastorali. L’obiettivo di Virgilio è quello di costruire un mondo coeso e solidale nel quale gli uomini si supportino reciprocamente facendo leva sulle debolezze e fragilità umane. Virgilio così abbandona l’ideologia dell’homo homini lupus, incentrando la sua produzione sulla parola “solidarietà”. È qui allora che Virgilio teorizza una sorta di rinnovamento totale, una palingenesi capace di ricostruire ab imis il mondo circostante. Verrà, secondo il poeta mantovano, un’età aurea dove un puer avrà il compito di ristabilire gli antichi dettami della societas romana.
Bucoliche: poesia e arte
Il genere bucolico romano tende a ricercare un’armoniosa fusione tra la cultura greca e quella latina; già con Orazio e in seguito con Virgilio questo progetto fu messo in atto. Ma tale commistione di generi trova tuttavia alcune notevoli differenze come l’atmosfera sensibile e malinconica dell’opera virgiliana. In essa l’autore proietta i suoi stati d’animo e la realtà contemporanea. Virgilio allora stabilisce con il modello teocriteo un rapporto di repetitio/inventio.
Egli infatti crede giusto ripeterne le strutture letterarie, i topoi, e gli stilemi, ma allo stesso tempo pensa di invenire strade nuove al fine di pervenire ad una sua originalità.
Superamento del neoterismo e dell’epicureismo nelle bucoliche
Dalle dottrine neoteriche ed epicuree Virgilio estrae il gusto per la trattazione di amori infelici e la visione della poesia come dotta e pastorale. Tuttavia rifiuta la visione ludica della poesia, in vista di contenuti più profondi e ricchi di pathos. Dalla propria formazione culturale eredita una dottrina che lo spinge a scrivere le bucoliche seguendo una precisa simmetria e un rigore formale, che lo associano prettamente alla politica augustea. Dal punto di vista epicureo Virgilio non ne segue in alcun senso i dettami, infatti sono assenti dall’opera la dottrina del “vivi appartato” e del paesaggio, visto come luogo idillico e lontano in cui si obliano le angosce. Nelle Bucoliche infine notiamo una vera e propria anticipazione dell’ideale regime augusteo, il quale si colloca in uno stato atemporale, contingente e metastorico.
Le Georgiche
Tra il periodo della produzione delle Bucoliche e quello delle Georgiche Virgilio entra a far parte del circolo di Mecenate. Allo stesso tempo a Roma lo scontro tra Ottaviano e Antonio premia il primo di questi due. Questi due fattori chiariscono le intenzioni di quest’opera, che mirava a raccogliere il consenso popolare dei ceti medi di tradizione agraria. In tal senso è facile immaginare che Mecenate avesse notato la passione per i paesaggi agresti di Virgilio, indirizzandolo in ambito politico. L’opera consta di quattro libri scritti in esametri nei quali Virgilio affronta in toto i problemi connessi con l’agricoltura, ampliando il tutto con degli excursus di sapiente doctrina ed erudizione.
Struttura e contenuto
L’apertura del poema è dedicata a Mecenate e ad Ottaviano. In seguito vi è la trattazione dei lavori agricoli e in particolare la descrizione dei prodigi celesti seguiti all’assassinio di Cesare. Ma ciò che emerge con chiarezza è la visione evolutiva del lavoro e della relativa fatica. Infatti, secondo Virgilio, l’uomo viveva in una “età dell’oro” in cui i frutti della terra crescevano spontaneamente. Ma per volere di Giove, preferendo che l’uomo non si adagiasse nell’ozio e nell’inerzia, si è passati all’ “età del ferro” ove l’uomo è costretto a lavorare duramente per ottenere i propri frutti. Tuttavia il passaggio dall’ “età dell’oro” all’ “età del ferro” è vista da Virgilio come un processo evolutivo, durante il quale è stato possibile lo sviluppo delle artes e delle tecniche di coltura. Nell’ opera troviamo inoltre la trattazione della coltivazione arborea, l’elogio della Saturnia Tellus con la quale l’Italia è vista come la più bella di tutte le terre, l’allevamento di bestiame, che gode da parte di Virgilio di una visione umanizzata, essendo gli animali esseri operanti nella natura, la peste del Norico, e l’apicoltura con la quale si apre un excursus con protagonisti Corico e Aristeo.
Concezione del lavoro e tradizione georgica greca
Nelle Georgiche Virgilio si impone come obiettivo quello di creare un comune denominatore della tradizione letteraria augustea. In essa appunto cerca di seguire elementi di vitalità, originalità e sensibilità. Egli inoltre, è in perfetta sintonia con i modelli antichi come Callimaco, Euforione, Fileta e Esiodo. Quest’ultimo infatti rappresenta il pater della poesia didascalica e georgica, da cui Virgilio riprende la concezione, seppur ambigua, del lavoro: esso infatti è visto come una punizione per gli uomini (vedi “il furto di Prometeo”) e allo stesso tempo una via di salvezza per riscattare sé stessi e riconciliarsi con gli déi.
Valore positivo del lavoro
In Virgilio allora il lavoro assume una componente evolutiva, concessa da Giove affinché fosse utile per acuire le capacità mentali e la forza caratteriale, a scapito dell’età primitiva dell’oro che perde di idealizzazione e di suggestione, affermandosi perciò il progresso dell’umanità. L’uomo di conseguenza diviene artifex fortunae sue, nel rispetto della divinità che è dispensatrice di aiuto e progresso. Nel modello di Esiodo, l’età di Zeus (Giove per i Greci) risulta in toto l’opposto della dottrina tendenzialmente stoica di Virgilio. Il lavoro diviene allora frutto della provvidenza divina di Giove.
Recupero della tradizione romana
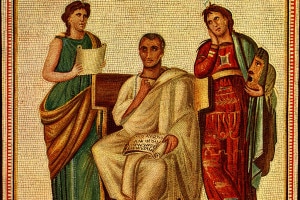
Nella scrittura delle Georgiche Virgilio utilizza diversi modelli riguardanti la letteratura romana:
- Catone; su di egli Virgilio contrappone il suo interesse perduto per la campagna a differenza della visione utilitaristica sulla conduzione dei fondi rustici; oltre questo Virgilio utilizza il senso dell’ humanitas e di sensibilità personale, contrapposto alla visione schiavistica di Catone;
- Varrone; egli rappresenta un trait d’union tra la poesia virgiliana e quella catoniana in quanto presenta una natura umanizzata e si pone in maniera benevola nei confronti del mondo schiavistico, seppur tenendosi alla larga dai dettami della produzione virgiliana;
- Lucrezio; da Lucrezio Virgilio riprende la visione filosofica dell’universo e la liberazione degli uomini dal timore della morte e degli dèi; con ciò Virgilio si pone sia in maniera critica verso le cose della natura, sia in maniera dogmatica rispetto agli dèi e alle credenze popolari; tuttavia vede sia la natura come “madre”, dispensatrice di frutti, sia come “matrigna”, quindi avara ed esigente.
Progetto delle Georgiche e ideologia del consenso
Nelle Georgiche troviamo delle chiare linee guida che rimandano al progetto augusteo: la pace, la tradizione e il lavoro agricolo. Quest’opera allora segue perfettamente le direttive di Ottaviano, il quale era intento a restaurare gli antiqui ac boni mores per ottenere una pace duratura e il prestigio perduto del lavoro agreste. Egli però non dedica la sua scrittura soltanto alla sfera politica e sociale; infatti, con la produzione georgica Virgilio si distacca dal filone dei poetae novi e porta a maturazione il processo di integrazione della letteratura nella società. Le Georgiche appaiono allora espressione di un Virgilio più maturo e consapevole, capace di trattare scelte di ordine politico e sociale, unitamente ai contenuti prettamente agresti.
Approfondimenti
Leggi anche:
- Virgilio: vita e opere
Vita e opere di Publio Virgilio Marone, poeta romano e autore delle Bucoliche, Georgiche e dell'Eneide. - Temi delle Georgiche
Riassunto dei 4 libri de Le Georgiche, il poema epico didascalico di Virgilio - Bucolica I di Virgilio: traduzione e analisi
Traduzione e analisi della Bucolica I di Virgilio, componimento in cui avviene l'incontro dei due pastori Titiro e Melibeo
Ascolta la puntata del nostro podcast dedicata all'Eneide di Virgilio
Ascolta su Spreaker.Un aiuto extra per il tuo studio
Recupera qui le opere di Virgilio:


